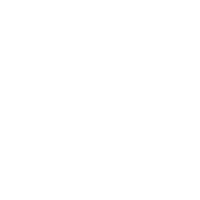settembre 2025
Wonderflow
La Fondazione Querini Stampalia di Venezia
La Fondazione Querini Stampalia è come un arcipelago di saperi eterodossi, radicata nella storia ma sempre in trasformazione. Invita a perdersi, a esplorare, a pensare. In questo senso, ogni visita è un esercizio di meraviglia, un invito ad abitare il mondo, a conoscerlo senza pregiudizi, a imparare senza preclusioni. È un arcipelago di esperienze dove la conoscenza si diffonde in modo rizomatico, eclettico e non gerarchico. Le isole intelligenti dell’architettura di Scarpa, Pastor, Botta e De Lucchi portano ognuna un segno plastico del proprio tempo e insieme compongono la complessità in un altissimo esempio di brillante convivenza.
La comune tensione verso un “abitare fluido” rende la Fondazione ed Edra partner d’elezione nel raccontare gli spazi come un’autentica connessione fra persone, natura e architettura. Alla Querini, l’Area Scarpa è l’esempio più compiuto di questa visione: un continuum che fonde interni e esterni, dove l’acqua della laguna entra ed esce dallo spazio architettonico al ritmo del lungo respiro delle maree, mentre il giardino, incastonato tra gli edifici come un hortus conclusus, si rivela luogo di stupefacente intimità. Qui la geometria razionale di Carlo Scarpa genera una inaspettata morbida apertura, invita alla contemplazione, lì dove luce e vento si mescolano alle note sonore e olfattive della Laguna.
Edra condivide questa stessa attitudine, i suoi sistemi di sedute non sono semplici arredi, ma dispositivi intelligenti che si adattano al corpo e al contesto, promuovendo un comfort su misura, valorizzando il gesto del rilassarsi come forma di dialogo attivo e ricettivo del paesaggio. Quando il pubblico attraversa il Portego, costeggia la Corte, si addentra nel giardino interno, ritrova la medesima armonia tradotta in volumi che cercano la profondità con le prospettive, le linee di fuga inaspettate unite all’effetto Droste come moltiplicatore di aperture. Al centro, un’esperienza sensoriale complessa che propone un’idea di ospitalità osmotica, che non separa mai l’indoor dall’outdoor, ma li integra in un unico grande progetto, offrendo la possibilità di abitare l’aperto, una realtà non definita e non determinata una volta per tutte, ma sempre in divenire, come il fluire dell’acqua che Carlo Scarpa, con una geniale intuizione, ha integrato all’interno del palazzo cinquecentesco affacciato sul canale e sul Campo Santa Maria Formosa. Per rendere quasi invisibile il confine visivo tra interno ed esterno, ha utilizzato il vetro, materiale autoctono, incastonando la sua architettura con maestria da orefice, il suo gioiello nel tessuto urbano di Venezia. Un paradigma dell’abitare aperto alla natura nella consapevolezza della sua continua e stratificata antropizzazione, ma nello stesso tempo nel tentativo di custodirne lo stupore e il mistero.
Alla Querini pratichiamo questo stupore, questa meraviglia come metodo e come progetto. Lo facciamo ispirandoci al nostro fondatore, Giovanni Querini Stampalia: un visionario che ha immaginato un’istituzione capace di restituire sapere, bellezza e cittadinanza al cuore di Venezia, in un’osmosi continua tra passato e futuro. Il nostro modo di abitare lo spazio nasce da una logica di apertura e di relazione. L’architettura di Carlo Scarpa è emblema di questo pensiero: un sistema fluido di soglie e transiti. Dentro e fuori si confondono, la città si insinua dentro il palazzo e il giardino si rivela come una stanza all’aria aperta che dà forma compiuta all’esperienza: il comfort, il fatto di stare bene a proprio agio, diventa un gesto culturale responsabile.
Il progetto Wonder Booster racchiude un insieme dinamico di arte, fotografia, scultura, architettura, design, libri e persone, definendo la “Qultura” della Fondazione, il suo segno distintivo che, il 5 maggio 2025, in occasione delle celebrazioni per il compleanno del Conte Giovanni, ha trovato pieno compimento in tre movimenti.
Il primo, le sculture di Davide Rivalta in Campo Santa Maria Formosa. Due leoni e due leonesse nel cuore di Venezia, come epifanie dell’“aperto”: soglie che mostrano la fragilità della nostra pretesa di dominare la distinzione tra umano e animale, resti di quel confine di cui abbiamo bisogno per definirci. Sculture, animali inerti, “visibili” solo come oggetti simbolici. Eppure, la loro presenza è “aperta”, non parlano ma non smettono di guardare. Sono il nostro controcampo silenzioso, la materializzazione dell’animalità inclusa, rappresentata e addomesticata nell’ordine umano. Eppure restano inquieti, come sul punto di incrinare la finzione, di restituirci la domanda sospesa: cosa ci distingue davvero? Siamo ancora capaci di riconoscere nell’animale un altro da noi? E quale relazione intratteniamo oggi con quella natura di cui siamo parte, come cellule di un unico organismo vivente?
Il secondo, Q Spot. Seat, read, think, repeat, progettato da Martí Guixé, trasforma il logo della Fondazione in una seduta sociale, invitando a sostare, leggere, riflettere e condividere, promuovendo la cultura come pratica quotidiana e allenamento per vivere il mondo. Un oggetto che abilita, dischiude la socialità come evento, predisponendo lo spazio per l’interazione pubblica, occasionale e dinamica. Un’opera come dispositivo comportamentale, come agente relazionale che modifica l’ambiente incoraggiando la comunicazione e la condivisione. Che dà la possibilità di abitare pacificamente e transitoriamente i luoghi e di sentirsi parte di un ambiente comune, temporaneamente ma in modo significativo, in cui la prossimità non è vincolo ma possibilità, e l’identità si costruisce nella differenza.
Il terzo movimento, la mostra inaugurale No Stone Unturned. Conceptual Photography, dedicata a John Baldessari, con oltre settanta opere che evidenziano il suo ruolo pionieristico nell’arte concettuale e nella fotografia, ma soprattutto il suo sguardo ironico e spensierato sulle cose, l’attrazione fatale per ogni dettaglio, anche quello apparentemente più insignificante, il gesto radicale a partire da sé, il nuovo inizio, la tabula rasa del Cremation project, da cui, come l’araba Fenice, è rinata ogni volta la sua arte. John Baldessari amava Giotto, amava tutta la storia dell’arte, anche quella che trovava noiosa. Per questo ha sempre cercato di prenderla con filosofia e di stupirsi per come sia sufficiente uno sguardo creativo e divergente per fare spazio all’immaginazione, un ars combinatoria che dà valore al mondo, una meraviglia che non ha niente di eccezionale quando diventa pratica quotidiana che ci fa stare al mondo e non evadere in un altrove che comunque, almeno per ora, si trova ancora da queste parti.